La prima nevicata

Ieri la neve è scesa su San Lorenzo Maggiore offrendo uno spettacolo a cui non siamo più abituati. Pubblichiamo delle foto del paese e della zona durante e dopo la nevicata

Ieri la neve è scesa su San Lorenzo Maggiore offrendo uno spettacolo a cui non siamo più abituati. Pubblichiamo delle foto del paese e della zona durante e dopo la nevicata

Abbiamo fotografato una sfera di pietra leggermente schiacciata ai poli, con un buco sulla parte superiore. Non riuscivamo a capire quale potesse essere stato il suo uso
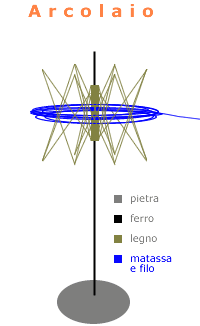
Poi abbiamo chiesto in giro fino a quando non abbiamo scoperto che si tratta della base in pietra di uno uìnnere (in italiano arcolaio) in cui era infilato il bastone di ferro su cui girava una intelaiatura di legno. Intorno alla intelaiatura era sistemata una matassa di lana (o altro materiale costituito da un lungo filo) per poterne ricavare gomitoli.

Tirando il filo, l’intelaiatura di legno girava intorno al bastone di ferro infilato nella base in pietra.
A destra è rappresentata schematicamente la struttura di un arcolaio del tipo considerato.
Le dimensioni della pietra riportata a sinistra sono approssimativamente 18 cm di circonferenza e 11,5 cm di altezza.

Negli ultimi anni la festa di Tutti i Santi e dei Morti viene anticipata da Halloween, una sorta di carnevale in cui si indossano maschere tetre ed orripilanti, importato da oltre oceano
Decenni or sono, i riti che caratterizzavano le celebrazioni delle due ricorrenze erano diversi.
La novena dei morti cadenzava i giorni che mancavano al 2 novembre. La recita della novena avveniva di mattina presto, all’alba.
Di sera, poi, appena faceva buio, un signore andava in giro per le strade del paese portando con sé un campanello che faceva suonare ogni quattro o cinque passi. Quando le persone nelle proprie abitazioni udivano il suono del campanello, si facevano il segno della croce, avvertendo una indistinta paura – quasi si trattasse di un oscuro presagio – e recitavano una preghiera per i morti, provando un profondo sentimento di pietà per i defunti.
I bambini andavano in giro per le case chiedendo un’offerta (che consisteva, di solito, in fichi secchi, castagne o fave secche) pronunciando questa frase:
I ragazzi, per creare un’atmosfera più suggestiva, si procuravano zucche non più buone per essere mangiate e le svuotavano. Vi intagliavano un volto con occhi, naso a forma di triangolo e bocca con grossi denti ben distanziati uno dall’altro ed accendevano una candela sotto ognuna di esse. Le lasciavano sulle finestre per tutta la notte. Il volto spettrale che avevano intagliato restava, così, visibile nel buio mentre la fiammella della candela accesa, all’interno, tremolava sinistramente ad ogni sbuffo di vento.
Per la Festa dei Morti si portavano candele al cimitero e si piantava la mertélla (forse piante di mirtillo) intorno alle sepolture. All’epoca non c’era la corrente elettrica così veniva acceso un cero magari utilizzando e mettendo assieme vecchi residui di cera trovati sulla tomba.
Il cimitero di San Lorenzo Maggiore si trovava dove ora sorge il centro polifunzionale (ex-macello). Per raggiungere il cimitero si scendeva per via Santa Maria e si attraversava un ponte che si trovava pressappoco davanti all’attuale municipio.
Alle ore 3 antimeridiane (prima dell’alba) del 2 novembre, ci si trovava nella chiesa di San Rocco dove celebrava le funzioni religiose don Peppe Lancia.
La chiesa di San Rocco si trova a circa 100 metri da piazza Antinora, salendo per via Capo (ora via Biondi). Veniva chiamata anche chiesa del Carmine perché lì si riuniva la Congregazione del Carmine e lì era conservata la Madonna del Carmine. Per inciso, nella chiesa di san Rocco era conservata anche la statua di San Stanislao ma non fu mai portata in processione a causa del suo rilevante peso (era costituita dalla statua del santo in piedi su una nuvola).
Nella chiesa di San Rocco veniva allestita una cascetellàna (“castellana”), costituita da una intelaiatura di legno a forma di parallelepipedo (grande più o meno come una bara), ricoperta da un drappo nero sul quale veniva posato un crocifisso di legno nero, di quelli che si reggono verticalmente.
Diverse persone si avvicendavano per intonare canti dedicati ai morti.
Le notizie che abbiamo fornito corrispondono ai ricordi di chi allora era adolescente per questo possono presentare delle inesattezze.
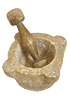
Una volta non c’era il sale fino: si comprava il sale grosso e poi in casa si pestava nel mortaio per sminuzzarlo. Abbiamo fotografato un mortaio (in dialetto mertàle) ancora in ottime condizioni

All’interno vi è il pestello in legno (in dialetto le pesatùre).
Durante la guerra per procurarsi il sale bisognava ricorrere alla borsa nera e spesso non era neppure pulito ma era frammisto a residui di terra e pietre. Per questo lo si lavava e lo si faceva asciugare prima di pestarlo.
Le dimensioni del mortaio sono 18 cm di circonferenza (23 cm se misurata includendo le protuberanze di pietra) e 11,5 cm di altezza.

Quest’anno il primo vento freddo è arrivato puntuale. E’ la voria de Sàn Pascàsie che proviene da nord e fa abbassare le temperature fino alla breve estate di San Martino
La vòria de Sàn Pascàsie arriva prima della terza domenica di ottobre, giorno in cui a Guardia Sanframondi si teneva la fèria de San Pascàsie.
I contadini, gli allevatori e gli artigiani della zona si ritrovavano per acquistare e vendere ciò che poteva essere utile per l’imminente inverno. Si vendevano castagne, maiali, tacchini (pìnte), asini, cavalli, capre, pecore, conigli (cùcce), galline, baccalà, peperoni da mettere sott’aceto, maglie e calze di lana, scarpe per contadini.
C’erano anche venditori che andavano in giro con una canna portata verticalmente dalla quale pendevano lunghe stringhe di cuoio (le curiùle) ricavate da pelli di cane. Per la particolare caratteristica di resistere alla trazione, esse venivano utilizzate come lacci per le scarpe dopo essere state trattate col grasso.

Quando non vi era la possibilità di acquistare un ciucciotto da mettere tra le labbra di un bimbo per farlo stare buono e zitto, si usava preparare quella che a San Lorenzo Maggiore veniva chiamata la pepatèlla
Era costituita da un cucchiaino di zucchero raccolto in un pezzo di stoffa di forma quadrata che veniva chiuso accostando i quattro angoli. Formava come un sacchettino. La parte contenente lo zucchero, veniva messa nella boccuccia del bimbo in modo che incominciasse a succhiare.
Se ne trova una traccia nell’episodio “Adelina”, interpretato da Sofia Loren, Marcello Mastroianni e Aldo Giuffré, del film Ieri, oggi, domani nella scena in cui Adelina (Sofia Loren) e Pasquale (Aldo Giuffré) si trovano ad accudire da soli, in casa, lo stuolo di figli di lei.
[ Compra ora il film “Ieri, oggi, domani” ] [ Info Commerciali ]
In attesa di compilare una bibliografia completa di Ernest Lawrence Rossi, proponiamo alcuni suoi libri acquistabili in modo semplice e veloce, direttamente da questo sito web
Per acquistarli, clicca sul titolo del libro e segui la procedura indicata.
 Nel libro “Altre storie di briganti” di Abele De Blasio sono riportati aneddoti ed episodi che vedono protagonisti alcuni dei più famosi briganti
Nel libro “Altre storie di briganti” di Abele De Blasio sono riportati aneddoti ed episodi che vedono protagonisti alcuni dei più famosi briganti
“Altre storie di briganti” – Prove di altropologia criminale
di Abele de Blasio (probabilmente scritto nel 1908)
ristampato nell’ottobre 2005
da Capone Editore & Edizioni del Grifo
come volume IV della collana Storie dal Sud
supplemento de La Gazzetta del Mezzogiorno
Nel libro di Abele De Blasio – di cui purtroppo non possiamo proporre l’acquisto on-line – sono riportati aneddoti ed episodi che vedono protagonisti alcuni dei più famosi briganti che, nel decennio successio all’unità d’Italia, costellarono di delitti e rapine le regioni continentali del Meridione e del versante orientale degli Appennini centrali fino all’Abruzzo.
Nel capitolo dedicato al brigante Cosimo Giordano si apprende che qualche elemento della omonima banda proveniva da S. Lorenzo Maggiore (p. 97) ed ancora che il 13 settembre 1862 fu proprio la banda di Cosimo Giordano ad uccidere Giuseppe Brizio di S. Lorenzo Maggiore (pp. 109-111). Secondo il racconto del De Blasio, Giuseppe Brizio insieme al sindaco di Guardia Sanframondi, avvocato Giovanni Pingue, ed a Raffaele Pigna, capitano della Guarda Nazionale in quell’occasione al comando di un drappello di quattro uomini, stavano recandosi a Cerreto Sannia per conferire col Sotto-Prefetto, quando si imbatterono in una banda di briganti di cui facevano parte Cosimo Giordano ed il “Pilucchiello”. Vi fu uno scambo di colpi di arma da fuoco e restarono a terra, senza vita, Giuseppe Brizio ed il brigante De Simone. I loro corpi furono portati a Guardia Sanfamondi e deposti nella congrega di S. Maria.
Il libro di De Blasio si conclude con testi di leggi emanate per tentare di arginare e stroncare il fenomeno del brigantaggio.
Dello stesso autore, segnaliamo i libri:
– Storie di briganti
– Inciarmatori, maghi e streghe di Benevento (rist. anast. 1900)
– Brigantaggio tramontato (rist. anast. 1908)
– Il tatuaggio (rist. anast. 1905)
 L’occupazione tedesca nella provincia di Benevento (8 settembre – 28 ottobre 1943)
L’occupazione tedesca nella provincia di Benevento (8 settembre – 28 ottobre 1943)
di Alfredo Zazo, libro pubblicato nel 1944
L’8 settembre 1943 le radio trasmisero il comunicato che annunciava la firma dell’armistizio tra il Regno d’Italia e gli Alleati. Le truppe germaniche in Italia mutarono atteggiamento nei confronti dei soldati italiani e della popolazione civile: se prima avevano diffidato del debole e pavido alleato, ora covavano rancore ed odio che, negli affioramenti improvvisi, incominciarono a costellare le contrade d’Italia di lutti e rovine: rappresaglie alle azioni di sabotaggio o all’atteggiamento ostile col quale le truppe germaniche venivano accolte.
Anche il Sannio pagò un tributo in quei mesi drammatici, un pedaggio di sangue per il transito delle truppe germaniche in ritirata.
Il libro L”occupazione tedesca nella provincia di Benevento (8 settembre – 28 ottobre 1943) di Alfredo Zazo, pubblicato nel 1944 – acquistato su questo sito e recapitatomi con i fogli rilegati ma ancora in parte intonso – ripercorre quegli avvenimenti ricostruendone la successione, dai primi bombardamenti alleati su Benevento nell’estate del 1943 sino alla fine dell’occupazione tedesca (28 ottobre 1943).
Il capitolo introduttivo è una cronistoria degli eventi bellici che ebbero come teatro il capoluogo sannita, sino all’ingresso degli Alleati in città.
La parte centrale e più interessante del libro è costituita dalla ricostruzione degli eventi bellici nei paesi della provincia. Ad ogni paese è dedicata una scheda in cui sono riportati sinteticamente gli eventi rilevanti, le azioni di rappresaglia, i nomi dei morti e dei feriti per causa di guerra.
Le quattro appendici conclusive, infine, sono, in ordine: l’elenco degli episodi rilevanti che ebbero luogo a Benevento dal 20 agosto al 3 ottobre 1943, tratto dal taccuino di un professore del Collegio de La Salle; la ricostruzione degli eventi e delle circostanze nelle quali il primo soldato sannita – Adriano Raffa – trovò la morte per mano germanica; l’occupazione tedesca e la successiva liberazione di Fragneto Monforte; l’opera di assistenza profusa dagli abitanti di San Gregorio, per iniziativa del parroco, in soccorso degli sfollati e dei soldati inglesi ed indiani che, evasi dai campi di concentramento, trovarono riparo nelle valli e sulle colline alle pendici del Matese.
A p. 71 è pubblicata la scheda dedicata a S. Lorenzo Maggiore. Si possono leggere i nomi delle due vittime del cannoneggiamento tedesco (uno dei quali di Guarda Sanframondi) e di un uomo ferito dai Tedeschi per non aver prontamente adempiuto ad una loro richiesta. Si apprende, inoltre, che i Tedeschi saccheggiarono abitazioni, asportarono ex voto d’oro e d’argento dalle chiese e derrate alimentari dall’ammasso locale. Ritirandosi, fecero saltare in aria cinque ponti nel tentativo di rallentare l’avanzata degli Alleati.
Presentiamo un elenco di libri sul Sannio, che potete acquistare con un semplice click, che spaziano dalla culinaria all’architettura, dalla storia alla magia
 Il Sannio e i Sanniti di Salmon Edward T., Einaudi, 1995
Il Sannio e i Sanniti di Salmon Edward T., Einaudi, 1995
Ultimi commenti