Oscuramento

Come in altre località d’Italia e d’Europa, anche nel nostro paese la guerra impose alla popolazione civile l’adozione di misure precauzionali sul rispetto delle quali vigilavano, in modo più o meno severo, le autorità militari e la milizia fascista
Tra le abitudini che i Laurentini furono costretti a mutare, vi erano quelle relative alla gestione della illuminazione pubblica (nelle strade) e privata (nelle abitazioni).
Le necessità dettate dalla guerra, imponevano ai centri abitati di non essere individuabili di notte, nell’oscurità, da eventuali aerei nemici che sorvolassero il territorio italiano perché avrebbero potuto sganciare bombe sulle case illuminate oppure orientarsi per raggiungere le destinazioni delle loro incursioni. Bisognava osservare le norme del cosiddetto oscuramento, cioè fare in modo che nessuna luce fosse visibile dall’alto. Era obbligatorio chiudere gli sportellini dietro le finestre delle abitazioni e spegnere le luci che potessero essere viste all’esterno. Chi aveva delle lampadine, le copriva con una calza nera per attenuarne il chiarore in modo che la luce che ne scaturiva risultasse più fioca.
L’oscuramento scattava alle ore 18:00 quando giovani fascisti giravano per le strade del paese incitando a spegnere le luci ed a coprire i vetri delle finestre in modo che non trapelasse alcun chiarore, gridando la frase: “spegnete le luci”.
Alle 18:00 scattava anche il coprifuoco – cioè il divieto di uscire per le strade se non in possesso di un particolare permesso – e durava sino alle ore 8,00 del mattino successivo.
Ringraziamo Romeo Ferrara per averci fornito tali notizie.
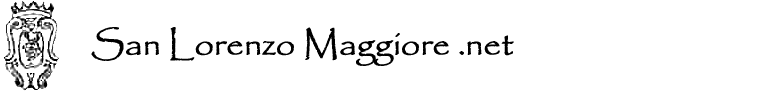







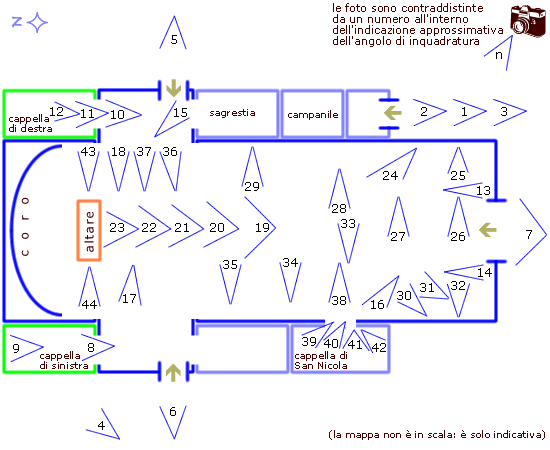
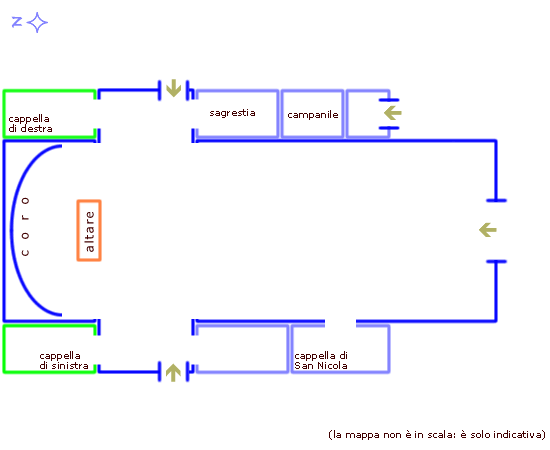












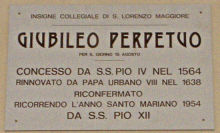
















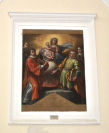























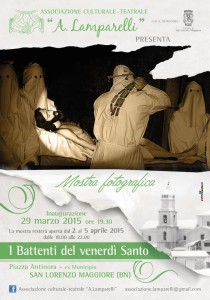
Ultimi commenti